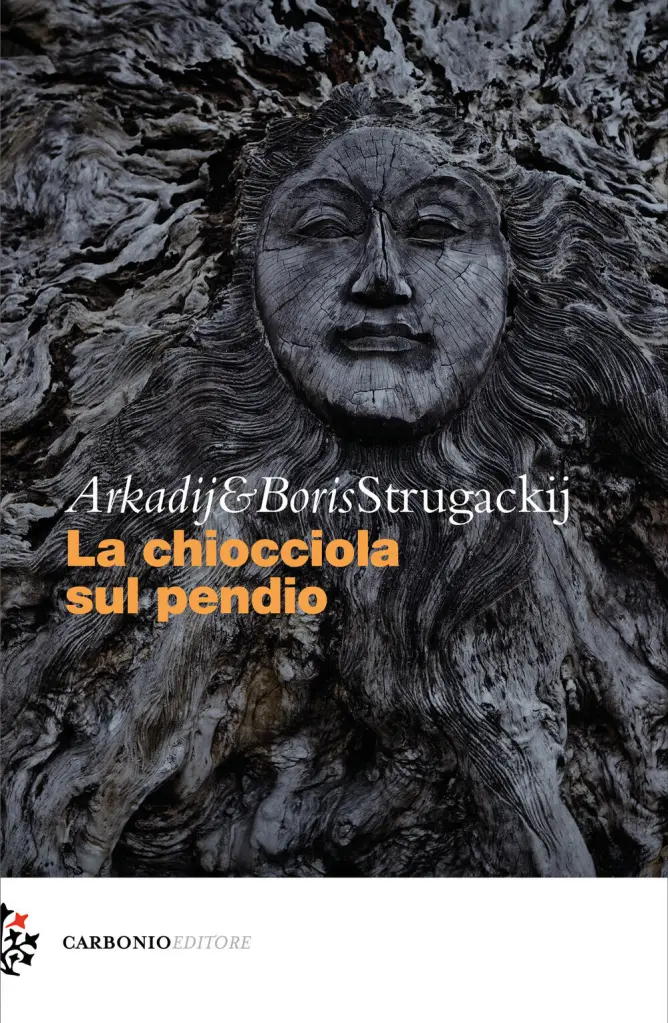È una fiaba nera e macchinina quella scritta dai fratelli Arkadij e Boris Strugackij, nel 1966 e ripubblicata oggi in Italia con il titolo simbolico e misterioso de “La chiocciola sul pendio”, edito Carbonio editore. Un romanzo tra distopia e parodia in cui i due scrittori sovietici dimostrano di sapere come pochi mischiare le atmosfere degli spiriti del folklore russo e gli incubi totalitari di Orwell e Huxley, il fascino soprannaturale di Bulgakov e le prigioni burocratiche dei romanzi di Franz Kafka. “La chiocciola sul pendio”, magistralmente tradotta da Daniela Liberti, segue le vicende di due personaggi tra loro complementari, Perec e Kandid, che abitano un mondo apocalittico e totalitario che mischia foreste stregate biomorfe e possedute con prigioni burocratiche e asfissianti.
Il mondo chiuso impenetrabile della burocrazia del “Direttorato”, simbolo della pervasività del potere statale, fatto di questionari, tesserini, permessi, carteggi e lasciapassare con quello selvaggio, informe e sciamanico delle selve biomorfe ed animiche degli incubi dei kulacki distopici della “Foresta”. Due mondi che si intrecciano fondando una allegoria macabra, distopica e satirica, che riflette sul rapporto tra individuo e società e su quello tra uomo e Natura.
Un conflitto riassunto dall’azione del Direttorato per la foresta, il cui controllo tecnocratico è esercitato anche sui propri subalterni, che vuole agire e colonizzare la foresta, mentre essa si ribella a questi tentativi di intrusione del potere umano. Il romanzo segue una trama sinottica che alterna capitoli incentrati su Perec a quelli concentrati su Kandid. Due personaggi le cui vicende non solo incarnano i conflitti dell’uomo in un mondo incontrollato e caotico, ma le cui riflessioni e ossessioni diventano il pretesto per spunti filosofici, dilemmi sul sottosuolo dell’uomo e quesiti etici sull’essenza e sull’esistenza dell’individuo, il potere, il progresso e la forza della Natura. Sono due fratelli separati Kandid e Perec, complementari e diversissimi, tormentati e disorientati le cui vite si intrecciano pur mantenendosi estranee, seguendo gli stessi percorsi esistenziali, senza però incontrarsi mai se non come aneddoti o voci di sottofondo.
Il primo è un giovane biologo, (il cui nome dal sapore volterriano riassume l’innocenza e il disincantato che si alternano nella vita di questo Candide distopico) che lavorava per il Direttorato della foresta, l’autorità responsabile di amministrare la foresta e da cui a un certo so distacca attraverso una rocambolesca fuga in elicottero finita tragicamente, che sopravvissuto allo schianto dell’elicottero avvenuto tre anni prima, ha temporaneamente perso la memoria ed è stato accolto tra le rurali popolazioni della foresta condividendone gli strani costumi e sposandone una dei membri, Nava.
Una coesistenza che inizialmente si rompe quando Kandid riacquista la memoria e tenta di ritornare ad una civiltà, descritta vagamente come Città, che si trova oltre la foresta e che vuole raggiungere. Perec, invece, è un linguista e filologo che si trova inspiegabilmente nel Direttorato, sul pendio che da sulla foresta, una struttura kafkiana, dalle regole e dalle procedure enigmatiche, in cui è “prigioniero” della routine e dalla liturgia della burocrazia che sovraintende alla foresta e da cui vuole fuggire. Due vicende parallele che si inseguono ed alternano nella “Chiocciola sul pendio” costruendo il ritratto fantasmatico di un mondo oppressivo e caotico, velato di menzogna e governato da forze naturali e statali mosse da regole assurde e desideri faustiani che rinchiudono il singolo in una prigionia totale, senza pareti, senza via di uscita.
Un’opera che, come hanno sottolineato gli stessi autori, più che alla fantascienza appartiene alla “fantacoscienza”, ossia ad una forma di letteratura proibita e allegorica (tamizdat) che non vuole solo divertire il pubblico, ma mostrare le inquietudini e i turbamenti dell’uomo moderno attraverso miti sci-fi che usano la distopia e gli elementi magici solo come pretesto o come maschera contro le angherie della censura sovietica. “Il Direttorato” è, infatti, una fortezza Bastiani in salsa sovietica, in cui gli uomini sono oppressi da un Moloch burocratico e tecnocratico che ne annienta la personalità e lo spirito soffocandolo dietro prigioni di scartoffie e procedure insensate in cui il coro delle voci, dei funzionari, delle circolari sommerge l’individuo come in un romanzo di Kafka, tra il Castello e Il Processo, o una trama di George Orwell. La “Foresta”, da par suo è invece l’esplosione dell’irrazionale, del soprannaturale, del magico sulle mire razionali e securitarie del Direttorato, una selva biomorfa e mostruosa abitata da streghe, sirene, macchinari steampunk, e popoli rurali arretrati e isolati del mondo che sono oppressi dalle leggi assurde delle forze primordiali della terra e dalle usanze coloniali degli uomini “civilizzati”.
Ma è proprio tra questi due non luoghi che i fratelli Strugackij inscenano i drammi dell’animo umano, la desolazione della società sovietica, la solitudine e lo smarrimento individuale in una sintesi unica degna di quella tradizione russa che annovera tra loro i Lermentov, i Gogol, i Bulgakov. “La chiocciola sul pendio” è infatti come la versione fantascientifica del Castello di Kafka girata da Elio Petri, come un incubo di Tarkovskij dopo aver letto i romanzi di Philip K. Dick e le fiabe del folklore russo. Un romanzo denso di simboli, di citazioni, di momenti poetici e altamente filosofici che sembra la sintesi perfetta tra “Neon Genesis Evangelion” e il “Maestro e Margherita”, un allucinazione cyberpunk e il diario proibito di un prigioniero politico del regime sovietico, che non vuole solo irridere, mostrare e disvelare le prigioni dell’uomo moderno, ma mostrare la storia di ogni uomo che vive una lotta impari contro le forze naturali, soprannaturali e innaturali che lo opprimono.
Una lotta che vivono Perec e Kandid, il cui destino è simile a quello della chiocciola che cerca di scalare il pendio, lentamente ed oppressa da mille difficoltà, del monte Fuji senza riuscirci. Rileggere i fratelli Strugackij, non vuol dire quindi solo leggere un capolavoro della fantascienza novecentesca grottesco e magico che nulla ha da invidiare a Stanislav Lem o Isaac Asimov, ma scoprire, o riscoprire, due tra i maggiori narratori del secondo novecento russo.